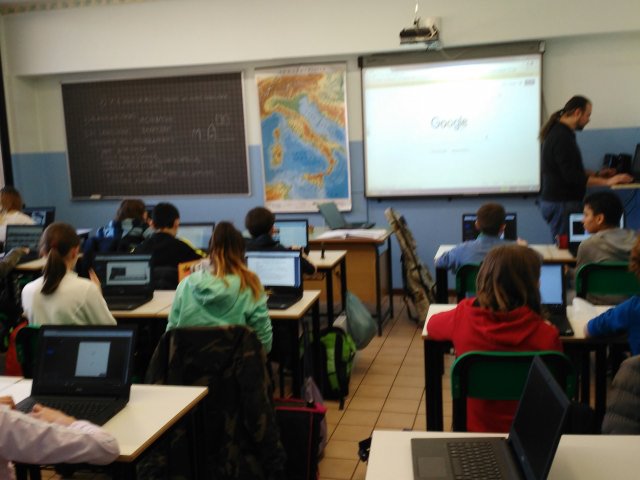Atelier creativi e laboratori per le competenze chiave
La scuola ha ricevuto, dal MIUR, un finanziamento per realizzare laboratori corredati da robot. Il piano è esteso a tutti gli ordini di scuola ma gli strumenti didattici e gli obiettivi saranno diversificati a seconda dell’età degli allievi.
Di seguito è riportato un sunto del Piano tratto dal sito del MIUR.
Il piano laboratori del Piano nazionale per la scuola digitale è connotato nella scuola del primo ciclo dalla realizzazione degli atelier creativi.
L’obiettivo è riportare a scuola il fascino dell’artigiano, del “maker” e dello sperimentatore, attraverso lo sviluppo negli alunni della consapevolezza che gli oggetti si possano progettare e creare. L’obiettivo è, inoltre, alla luce dei progressi delle tecnologie digitali e del loro impatto su società ed economia, creare laboratori che consentano la produzione di video, di apps e giochi, di arte e musica digitale, e che costituiscano un accesso alla realtà immersiva dove, ad esempio, si può proporre una didattica basata sullo storytelling o metodologie di didattica attiva. I laboratori possono rappresentare uno stimolo all’innovazione della didattica delle discipline standardizzate e, gradualmente, di tutta la dinamica scolastica, nell’ottica di un più profondo cambiamento educativo e culturale.
Perciò, se gli atelier vanno pensati come l’ambiente in cui si mettono in campo le competenze allora il punto di partenza non può essere semplicemente l’acquisto delle dotazioni, ossia la c.d. “lista della spesa”; non vi sono modelli o pacchetti da acquistare confezionati da altri: il punto di partenza è la progettazione unica e originale di ogni singolo istituto:
- l’idea: si tratta della prima ispirazione. Il pensare per la propria scuola ad un ambiente dove fare esperienze per le competenze; che ambisca a coinvolgere il maggior numero di classi/studenti; che incoraggi la creatività, la manualità, il gioco, l’uso critico dei media e il pensiero progettuale usando anche le tecnologie; un incubatore di idee dove gli studenti apprendono e mettono in pratica curiosità e fantasia; un punto di incontro tra apprendimento formale e informale, tra materiali e strumenti antichi e d’avanguardia.
- il design delle competenze attese: l’ispirazione deve concretizzarsi e calibrarsi sulle necessità e sulle condizioni di fatto delle singole scuole; il suo impiego può essere integrato nel curricolo sia disciplinare che interdisciplinare, mirato al raggiungimento di percorsi di competenza, prevedendo anche nuove modalità di valutazione formale, affinché le attività non vengano derubricate a “extrascolastiche”. Per le ore curricolari l’atelier può essere pensato per realizzare progetti basati sulla didattica per competenze; ma può essere anche uno spazio per la comunità, con apertura al territorio e ai genitori o a studenti di altre scuole. Utilizzabile dai docenti per attività di formazione, può essere l’ambiente dove aggregare gruppi verticali, dall’infanzia alla secondaria di primo grado; oppure, anche attraverso dinamiche cooperative e collaborative, per gruppi aperti o orizzontali su più classi, con un approccio progettuale più metodologico che tecnologico.
- la progettazione partecipata: così come le metodologie costituiscono le basi della progettazione, così anche le modalità della sua realizzazione richiedono una attenzione particolare. È auspicabile un lavoro di progettazione partecipata coinvolgendo oltre ai docenti – nel più ampio numero possibile – e agli studenti – con livelli di protagonismo a seconda dell’età –, varie e specifiche professionalità (tecnologi, artigiani, architetti, ecc).
Una dimensione di comunità utile non solo all’atto della sua realizzazione, ma anche al suo sviluppo nel tempo, grazie all’interazione con altre realtà territoriali quali spazi di coworking, fab lab, incubatori, università, centri di ricerca, associazioni per favorire un utilizzo condiviso delle risorse e la diffusione dei progetti realizzati all’interno di singoli laboratori.
La diffusione di un nuovo tipo di laboratori nelle istituzioni scolastiche, finora realizzati da esperienze molto motivate e in qualche modo molto assistite e guidate, richiede anche un nuovo tipo di linguaggio condiviso. La stesura del progetto può ispirarsi alle parole che possono connotare la propria idea di atelier, tra cui:
- Talenti: tra creatività e manualità – lasciare spazio alla creatività, alla soluzione di compiti reali, ma anche riappropriarsi del lavoro con le mani;
- Linguaggi: tra umanistici e numerici – scoprire i linguaggi dei bambini per conoscere la realtà che li circonda;
- Competenze: tra autonomia e relazioni (a seconda dell’età dello studente, mirare a una crescita autonoma, anche se progettando insieme);
- Metodologie: tra processo e prodotto – curare molto il processo didattico senza trascurare un prodotto finale concreto necessario per la motivazione e l’autovalutazione;
- Saperi: tra discipline e aree di incontro trasversali – impostare curricoli orizzontali, verticali, di collaborazione legati alla laboratorialità disciplinare, ma anche a competenze di cittadinanza digitale;
- Scoperta e ricerca: tra osservazione/ricerca e sperimentazione/invenzione – lo studente può fare esperienza attraverso percorsi di scoperta immersiva reale e virtuale, ma anche diventare ricercatore, artigiano, “praticare” i saperi;
- Tecniche e strumenti: tra artigianato e tecnologia – affiancare macchine o strumenti, antichi e moderni e farli rivivere;
- Materiali: tra curricolo e materiali – riscoprire una didattica degli oggetti, delle cose, dei materiali già legati alle discipline del curricolo e farli interagire con le tecnologie.
Gli spazi, preferibilmente più grandi di un’aula convenzionale per offrire una qualità diversa dello stare a scuola, per modificare i gruppi classe e per ospitare più attività contemporaneamente, possono essere progettati a partire da alcuni elementi base, ispirati alla flessibilità e all’organizzazione dell’ambiente di apprendimento e dei suoi elementi.
Tutte le scelte sono fortemente condizionate dalla superficie dell’ambiente individuato come sede dell’atelier e dalla progettazione didattica dello stesso2. Si tratta di un’analisi che richiede il coinvolgimento della comunità scolastica, ma anche di figure esperte nel design degli spazi.
Setting variabili
I setting variabili sono ottenuti mediante isole di lavoro e postazioni con un numero variabile di studenti che permette di gestire la pianificazione dei progetti più agevolmente.
Dovendo interagire nell’atelier strumenti e contenuti sia analogici che digitali e concependo uno spazio didattico fluido che supera la fissità dell’aula, risulta molto importante concepire lo spazio e il suo orientamento in funzione dell’impiego simultaneo di schermi e superfici per la ricerca e l’annotazione.
A seconda delle scelte progettuali e della grandezza dello spazio individuato potrebbe essere opportuno realizzare delle zone specializzate all’interno dell’atelier, come percorsi o come set di esperienza reale o virtuale per scoprire o promuovere i talenti degli studenti anche nel campo della produzione di audio, video, suono, anche attraverso l’uso di strumenti digitali; oppure come aree “generaliste” di tinkering o di stampa 3D. Pertanto, è importante prevedere l’impatto e la successiva fruibilità di strumenti che contemplino l’uso dello spazio, del suono o delle luci anche in contemporanea con altre attività interne all’atelier.
Se necessario, si può prevedere, anche attraverso arredi mobili e dispositivi individuali o collettivi su carrello, la possibilità di creare temporaneamente degli ambienti separati (studioli), in base alla tipologia di aggregazione dei gruppi di lavoro e al grado di responsabilizzazione e autonomia degli studenti.
La scelta dei colori per pareti, porte, arredi è un aspetto molto significativo, anche di coprogettazione. Questa è un’opportunità per analizzare le potenzialità che le scelte dei colori portano con sé in termini di benessere, piacevolezza, energia. Analogamente, l’integrazione di luci naturali e di luci artificiali, insieme all’individuazione di possibilità di zone di luce o di ombra, costituiscono un fattore importante per l’efficacia dell’uso dell’atelier.
L’aspetto della sicurezza, considerando la compresenza di dispositivi mobili e fissi al fianco di strumenti per la manualità e la creatività anche elettrici, richiede uno studio attento della dislocazione e dei carichi prevedibili per i punti di accesso all’elettricità e alla rete.
Le istituzioni scolastiche possono trarre ispirazione da una delle seguenti, indicative e non esaustive, tipologie di atelier (cfr. allegati 2 e 3). Questi schemi sono stato pensati con una dotazione di base (il cosiddetto “tappeto digitale”) comune ad ogni atelier e con due specifiche dotazioni, di cui una a bassa specializzazione e una ad alta specializzazione, prevedendo una configurazione di attrezzature specifiche legate al progetto educativo dell’istituto.
Si tratta delle “condizioni digitali” comuni a entrambe le tipologie di atelier, già esistenti o da implementare nella scuola: banda larga e reti locali, varie tipologie di dispositivi individuali o collettivi, arredi mobili e modulari, ecc.. Questa base comune e abilitante ad ogni atelier va concepita anche in vista di una apertura al BYOD (Bring Your Own Device), ossia alla possibilità che gli studenti portino a scuola un proprio dispositivo (tablet, computer portatile, etc.) e lo usino insieme ai dispositivi (fissi e mobili) presenti nell’ambiente, in base alle necessità didattiche, fornendo all’insegnante un più ampio ventaglio di possibilità.
A questo si aggiunge che la proposta progettuale da presentare dovrà fornire delle soluzioni per creare:
- Atelier a bassa specializzazione e ad alta flessibilità: generico, orientato alla creatività e allo sviluppo di competenze trasversali. Si possono introdurre dispositivi per connotarlo di volta in volta, abilitato all’introduzione di nuovi strumenti. Al suo interno può trovare posto, per esempio una “Tinkering zone”3 – che non ha una traduzione esatta in italiano, ma letteralmente significa armeggiare, trafficare – per sperimentare in modo diverso la scienza e la tecnologia, utilizzando prima di tutto la creatività come strumento per relazionarci e per comprendere ciò che ci Un potenziale simile è intrinseco nei laboratori dedicati al disegno e alla prototipazione rapida (i cosiddetti “Fab Lab”4), dove è possibile per gli studenti seguire tutti i passi per la progettazione e la costruzione di oggetti fisici anche di elevata complessità. Un ambiente didattico eccellente per stimolare la partecipazione, un modo empirico per apprendere impegnativi concetti di natura scientifica.
- Atelier ad alta specializzazione e a bassa flessibilità: costruito su un filone tematico o sull’intersezione tra filoni tematici più specifici: scientifico, artistico, umanistico, musicale, trasversale, artigianato, arte digitale, specifici bisogni speciali; percorsi interattivi. Integrando tecnologie, strumenti e design nell’atelier si potrà lavorare all’intersezione tra arte e scienza, ponendo ciascun partecipante nella condizione di sviluppare competenze chiave della società contemporanea come la creatività, la capacità di innovazione, il pensiero critico, l’imprenditorialità e la flessibilità e competenze su temi specifici, come robotica, energia sostenibile e tecnologie verdi, artigianato del territorio, arte e musica digitale, ecc.